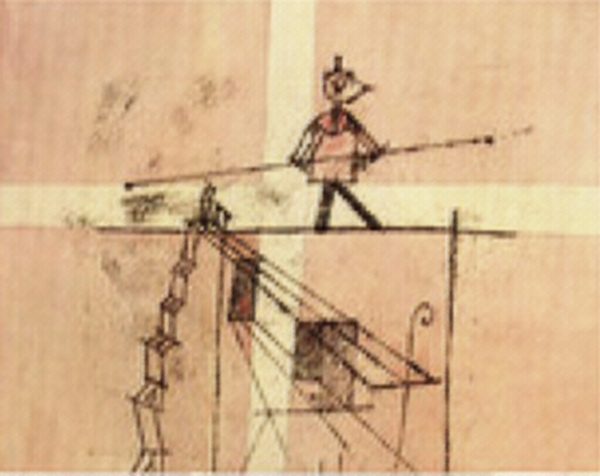Antonio Tricomi ha appena pubblicato Cronache letterarie (Galaad, Giulianova 2017, pp. 305, euro 15,00), che la quarta di copertina presenta cos√¨: ¬ęOvviamente queste non sono cronache letterarie. Non inseguono infatti, n√© desiderano vagliare sistematicamente le principali novit√† editoriali. Scelgono piuttosto di sondarne pazientemente alcune con l‚Äôintento di valorizzare la tradizionale attitudine del saggismo: prodursi in classici esercizi di critica della cultura. √ą dunque in primo luogo una riflessione sul nostro tempo quella che, pagina dopo pagina, lentamente emerge dall‚Äôassiduo corpo a corpo con scrittori quali Affinati, Broch, Carr√®re, De Angelis, DeLillo, D√ľrrenmatt, Falco, Houellebecq, J√ľnger, Lagioia, Pynchon, Joseph e Philip Roth, Saviano, Siti, Vasta. Cos√¨, mentre pur ne ammette l‚Äôormai cronica sterilit√† sociale, Tricomi comunque si ostina a scorgere nella critica letteraria un raffinato strumento di conoscenza¬Ľ. Si offrono, qui di seguito, due di queste ‚Äúcronache letterarie‚ÄĚ. Ringraziamo l‚Äôautore per averci concesso di pubblicarle.
 
Libere associazioni di senso
E se Arg√©man (Marcos y Marcos, Milano 2014) fosse la pi√Ļ bella raccolta di versi di uno dei maggiori poeti italiani in attivit√†? Certo √® che, quand‚Äôanche le cose stessero altrimenti, si rivelerebbe comunque il libro in cui il disciplinato e tuttavia prensile io lirico, al quale Fabio Pusterla √® solito offrire la sua voce, riesce a spremere dalla lezione di Vittorio Sereni il modello di sorvegliata e per√≤ non reticente poesia civile, che risponde forse meglio alla pudica vocazione conoscitiva che sempre ne orienta una colta ma appassionata pronuncia, quindi fisiologicamente incline a introiettare e ridefinire in chiave espressivistica obiettivi culturali e strategie retoriche peculiari della saggistica. Ancora pi√Ļ di Folla sommersa ‚Äď l‚Äôopera da questo punto di vista fin qui esemplare, tra quelle proposteci dall‚Äôautore nato a Mendrisio ‚Äď, Arg√©man compie infatti il piccolo, grande miracolo di descrivere, interrogare e in parte anche giudicare il nostro tempo con puntuale accortezza esegetica e sicura attitudine autocritica, ma senza nulla concedere n√© a tentazioni predicatorie o toni tribunizi, n√© a forme di euforico o apocalittico autocompiacimento di natura intellettualistica.
Un dettato assai versatile ‚Äď e dunque pronto, per assecondare l‚Äôambizione mimetica che lo governa, sia a contrarsi nell‚Äôesatta misura di versi cristallini, sia a rigettare qualunque gabbia metrica per arrivare, in alcuni casi, a espandersi in levigati lacerti di prosa ‚Äď cerca allora di cogliere ‚Äď nelle pieghe di un convulso presente che pare sistematicamente sottrarsi a ogni sforzo di non preconcetta interpretazione univoca ‚Äď improvvisi riverberi o segrete tangenze di senso impegnandosi a individuare gi√† riconoscibili o solo potenziali rapporti tra frammenti di realt√† magari lontani gli uni dagli altri. Non per nulla, ‚Äúarg√©man‚ÄĚ ‚Äď ci informa la Nota dell‚Äôautore che chiude il volume ‚Äď √® un ¬ętermine dialettale di origine misteriosa¬Ľ cui si ricorre per indicare tanto ¬ęle lingue di neve o di ghiaccio che restano perennemente in certi anfratti di montagna¬Ľ, quanto ¬ęuna valanga e i suoi resti¬Ľ. √ą per√≤ altres√¨ indubbio ‚Äď ci ricordano ancora le ultime pagine del libro ‚Äď che Nahal Argeman √® un villaggio della Palestina; che l‚Äô‚Äúiris argeman‚ÄĚ √® un fiore purpureo del deserto; che le ‚Äúargema‚ÄĚ sono ¬ę‚Äúpiccole ulcere del giro dell‚Äôiride‚Ä̬Ľ; che l‚Äô‚Äúargemone‚ÄĚ (o ‚Äúargemonia‚ÄĚ o ‚Äúargemonion‚ÄĚ) √® un ¬ę‚Äúpapavero messicano o spinoso‚Ä̬Ľ ritenuto un tempo ¬ęin grado di curare l‚Äôargema¬Ľ.
Non si tratta ‚Äď sembra cio√® suggerirci Pusterla ‚Äď di piegare le plurivoche costellazioni di senso, che la nostra epoca e la storia dunque ci offrono, a una poco plausibile narrazione unitaria che rinnegherebbe dispoticamente la pluralit√† di significati da quelle evocata, ma di accostarsi, con laica ed estrema umilt√†, alla polisemia del reale per ricavarne un‚Äôimprescindibile lezione su come andrebbero intesi il diritto-dovere del singolo alla conoscenza e l‚Äôaspirazione al sapere di ciascuna societ√†: al pari non di perentorie e assolute affermazioni identitarie, ma alla stregua di empiriche e inesauribili ricerche di una per statuto irraggiungibile verit√† ultima. Non √® allora un caso che Arg√©man sia forse la raccolta di versi di Pusterla nella quale l‚Äôesperienza di docente, tuttora vissuta dall‚Äôautore, pi√Ļ e con maggior profitto emerge, ribadendo la garbata inclinazione pedagogica della sua poesia. Chi insegna a scuola sa infatti bene di essere anzitutto richiesto di educare le nuove leve al rispetto dei principi fondamentali della democrazia.
 
Tante anonime creature fragili
Bench√© egli abbia brillantemente curato l‚Äôedizione commentata del Diario del‚Äô 71 e del ‚Äô72 di Eugenio Montale (Mondadori, Milano 2010) e steso una lucidissima nota introduttiva all‚ÄôOscar Poesie 1975-2012 di Franco Buffoni (Mondadori, Milano 2012), la sensazione √® che il trentanovenne Massimo Gezzi ‚Äď scrupoloso interprete anche di autori quali Paolo Volponi, Bartolo Cattafi, Antonio Porta, Giovanni Raboni ‚Äď nel calibrare la sua proposta poetica desideri mettere principalmente a frutto, rivisitandole, le lezioni di altri due maestri: Vittorio Sereni, che ne risulta quasi l‚Äôimprescindibile modello lontano, e Fabio Pusterla, che per lui sembra invece costituire un pi√Ļ vicino e naturale interlocutore o addirittura, se non un padre, almeno un fidato fratello maggiore e un esemplare compagno di strada. Il numero dei vivi (Donzelli, Roma 2015), pubblicato nei mesi scorsi dall‚Äôautore marchigiano, √® un libro che credo confermi questa impressione.
Come nei suoi precedenti volumi di versi, ma con lucidit√† e sagacia forse maggiori, Gezzi mi sembra infatti assecondare il duplice movimento connaturato alla generosa intuizione lirica del reale che sempre ne alimenta il dettato. Da una parte, la sorgiva inclinazione dei suoi testi a veicolare gli stati d‚Äôanimo e le pretese veritative della pura soggettivit√† poetica, che ad essi d√† forma, aspira cio√® a contenere il proprio oltranzismo espressivo e a limitare le proprie rivendicazioni ermeneutiche, per approssimarsi, talora in modo esplicitamente conflittuale, alla misura, anche etica, della pi√Ļ disciplinata e razionale colloquialit√† che contraddistingue una prosa quando descrittiva, quando argomentativa. Dall‚Äôaltra parte, gli abituali esiti di questa indotta propensione discorsiva sono perlopi√Ļ caratterizzati da una tale densit√† stilistica, pur mai autoreferenziale, e da una tanto insistita, bench√© in nessun caso vuota, allusivit√† semantica, che essi riescono letteralmente a rigenerare l‚Äôostinazione lirica che li aveva visti nascere; convertendola subito, da potenziale rifiuto aprioristico del senso comune e del commercio con la realt√†, in umile ma rigoroso confronto a tutto campo con il presente o, per meglio dire, in garbata e per√≤ intellettualmente avvertita presa di possesso individuale del mondo.
Se nel nostro tempo ‚Äď sembra insomma volerci suggerire il poeta ‚Äď ci sentiamo oramai gettati senza bussola alcuna che sappia orientare il cammino di tutti e di ciascuno, perch√© nessuna credibile mitologia comunitaria di segno emancipatore pare pi√Ļ offrirsi alle diverse decodifiche soggettive, allora non resta, a ognuno di noi, che predisporre la propria indifesa, proteiforme, tenace sensibilit√† all‚Äôincontro, non di rado frustrante, con un sempre pi√Ļ intangibile o enigmatico esistente, per ricavare da tale corpo a corpo finanche con l‚Äôassurdo una disillusa, mai dogmatica, instancabilmente versatile intelligenza comunque sia dolorosa delle cose, piccole e grandi. Del resto ‚Äď lascia intendere ancora Gezzi, che forse non a caso svolge il mestiere di docente di Italiano in un Liceo di Lugano ‚Äď solo a quanti accettino di comportarsi in tal modo risulta davvero possibile confluire, per l‚Äôappunto, nel ¬ęnumero dei vivi¬Ľ. Tra i quali si rivela in aggiunta lecito comprendere esclusivamente quei poeti che siano riusciti a far dialogare ognuno il proprio autentico io lirico con l‚Äô¬ęincompiuta congrega di persone¬Ľ che ¬ęHanno potuto quel che hanno saputo¬Ľ, che certo hanno talvolta ¬ęsbagliato¬Ľ, ma che ‚Äď al pari appunto dei migliori autori letterari ‚Äď mai hanno cessato di tutelare il loro inconfondibile, prezioso ¬ęnulla / che non smette di essere¬Ľ.
Cos√¨, tra i componimenti pi√Ļ significativi inclusi da Gezzi nella sua recente raccolta di versi meritano forse di essere in primo luogo citati testi come Discorso ai nuovi vicini o Ultima domanda e, in generale, tutti quelli in cui, magari ripensando la lezione di Giovanni Giudici, l‚Äôautore sembra quasi farsi non retorico e disilluso, compitissimo e dolente cantore mai epico di quella sempre pi√Ļ violata ed esigua dimensione domestica alla quale molti individui affidano quotidianamente il progetto, spesso vano, di ¬ędifendere¬Ľ il loro ¬ęperimetro di spazio¬Ľ affettivo, o nella quale ‚Äď stritolati da un ¬ępresente¬Ľ che appare ¬ęuna speranza / che contraddice se stessa, bene e male / che si elidono¬Ľ ‚Äď si sorprendono a dubitare persino di essere in vita, pur avendo in tal misura ridotto le proprie pretese esistenziali da ambire soltanto a non doversi scoprire emotivamente morti. Anonime creature fragili chiamate a rivendicare, senza compiacimento alcuno, la dignit√† della propria debolezza non gi√† con l‚Äôintento di offrirla al mondo che le oltraggia quale comodo alibi per ciascun sopruso che esso voglia riservare loro, ma per trasformarla ‚Äď verrebbe da aggiungere: leopardianamente ‚Äď in non solo ideale sostegno reciproco allorquando si tratti di provare a fronteggiare questa o quella aggressione: ecco cosa noi tutti sembriamo a Gezzi. Almeno a giudicare da quelle Sette raccomandazioni alle foglie cadenti in cui egli ad esempio scrive, rivolgendosi appunto a siffatti emblemi non si saprebbe in verit√† dire se di vita ormai ridotta integralmente a morte o di morte che non √® in grado di cancellare del tutto la vita: ¬ęDifendetevi, infoltite. Se il vento vi sferza, stringetevi assieme: quando l‚Äôuna si sbilancia, l‚Äôaltra la sosterr√†¬Ľ.
E se l‚Äôobiettivo del poeta deve essere quello di rendere omaggio, oltre che al proprio, a qualsiasi altro moralmente degno tentativo individuale di sottrarsi a ogni forma di codardo sconforto nichilistico, in un libro che gi√† si dimostra l‚Äôopera di un autore maturo (dal quale, per il futuro, occorrer√† in pi√Ļ solo attendersi che impari a resistere senza rimpianti alla tentazione di qualche scolastico ammiccamento di troppo), c‚Äô√® forse un testo che, fin dal titolo, spiega come un simile traguardo possa essere raggiunto: Unisci i puntini. Per chi compone versi, urgerebbe cio√® concepire questi ultimi come ¬ętracce¬Ľ o ¬ęcifre¬Ľ da collegare le une alle altre per far lentamente emergere un ¬ędisegno¬Ľ complessivo che sia poi quello della nostra plurivoca ¬ęmemoria¬Ľ storica e delle tante ¬ędifferenze¬Ľ soggettive che, con la loro irriducibile vitalit√† e tutte assieme, continuano a costruire una civilt√† ancora capace di schivare la catastrofe.