1. Un linguista ossessionato
¬Ý
Mi concentrerò sulla conferenza tenuta il 21 ottobre del 1975 al Liceo Palmieri di Lecce, che Pasolini decise di intitolare Volgar’eloquio recuperando un brano da Bestia da stile (1974), con l’obiettivo di collocare con esattezza all’interno della sua opera quell’intervento che rappresenta l’ultima occasione nella quale lo scrittore partecipò a un dibattito in pubblico prima dell’assassinio. Per farlo, dobbiamo immaginarci il suo tavolo di lavoro a quell’altezza cronologica: si trattava di un laboratorio o di un’officina febbrile, un coacervo ricco di travasi e osmosi intertestuali e intermediali, ripensamenti, ricerche in corso attraversate da un filo rosso che ricongiunge gli esordi alle ultime opere, il primo all’ultimo tempo del suo percorso intellettuale e biografico.
¬Ý

¬Ý
Pensando al suo ultimo anno di vita, Pasolini incrocia come sempre vari generi letterari e codici artistici: pubblica gli Scritti corsari e lavora al film Sal√≤ e alla Divina Mimesis, un progetto di riscrittura della Commedia di Dante ideato molti anni prima; sta completando la stesura del suo romanzo, uscito postumo nel 1992, Petrolio, e d√Ý alle stampe una riedizione, o meglio, una riscrittura profonda delle poesie friulane giovanili, La nuova giovent√π. Qual √® il filo conduttore, l‚Äôelemento di continuit√Ý che tiene insieme la conferenza di Lecce al Palmieri, il pomeriggio a Calimera (dove si rec√≤ nello stesso 21 ottobre per ascoltare uno spettacolo improvvisato di musica grika), e le sue ultime aree di interesse e di intervento? Si potrebbe sostenere che ci√≤ che emerge da questo palinsesto di testi, scritture e incontri pubblici √® l‚Äôassillo che nutre la sua opera sin dagli esordi: la partecipazione civile e l‚Äôanalisi spregiudicata della societ√Ý italiana, da un lato; e dall‚Äôaltro lato le osservazioni sulla lingua, l‚Äôinteresse per i dialetti e l‚Äôinterrogazione sulla sopravvivenza o la scomparsa della cultura popolare.
Lingua e dialetti, cultura popolare e subalterna: sono le coordinate, variamente modulate e correlate, che attraversano in lungo e in largo la sua parabola intellettuale e artistica e la sua stessa biografia. Pasolini scriver√Ý di ¬´fraternit√Ý umana¬ª come istintivo trasporto che gi√Ý nel periodo friulano lo legava sul piano sentimentale e intellettuale, tra ¬´passione e ideologia¬ª, alle ¬´persone vive¬ª e alle lingue, alle culture dei Sud, delle province o delle periferie d‚ÄôItalia e del mondo (¬´persone vive¬ª √® una formula di Ernesto de Martino). I ceti subalterni, annotava Gramsci nei suoi Quaderni, ¬´non hanno storia¬ª, nel senso che la loro presenza ¬´non lascia tracce nei documenti storici del passato¬ª, ma allo stesso tempo sono portatori di forme culturali, visioni del mondo, valori autonomi e capacit√Ý di espressione: in quanto si esprimono attraverso i dialetti ‚Äì ai quali √® dedicato l‚Äôincontro al Palmieri del 21 ottobre 1975 ‚Äì e attraverso la musica, i canti popolari che Pasolini ascolta dal vivo in quello stesso pomeriggio a Calimera[1].
Partendo dal precetto di Uccellaci e uccellini che invitava a ¬´mangiare i maestri in salsa piccante¬ª (l‚Äôunico modo di rispettare i maestri √® renderne controversa, e cio√® viva, la lezione, senza venerarli come fossero dei cadaveri imbalsamati), possiamo sostenere che i maestri ai quali Pasolini √® rimasto per sempre fedele, sebbene de lonh e pur nelle tante contraddizioni del suo percorso, siano stati proprio Gramsci insieme a Roberto Longhi e Gianfranco Contini, autore come sappiamo della prima recensione alle Poesie a Casarsa. In dialogo con gli studi continiani e con i primi saggi di critica stilistica pubblicati in Italia, Pasolini si definisce gi√Ý negli anni Cinquanta un ¬´linguista ossessionato¬ª (come scrive nell‚Äôintroduzione a I parlanti, una prosa risalente al 1951 che appare nella nuova edizione del 1979 di Ragazzi di vita): √® precoce, insomma, la passione e l‚Äôattenzione anche filologica prestata alla poesia popolare e al dialetto. Ci√≤ che interessa Pasolini, che segue in questa direzione il pensiero di Gramsci, √® il rapporto conflittuale e dialettico tra lingua e societ√Ý nel corso del tempo. In un libro che raccoglieva alcuni articoli degli anni Sessanta, intitolato Le belle bandiere, con prefazione di Tullio De Mauro, Pasolini citava a memoria un passo dai Quaderni del carcere: ¬´Ogni volta che affiora, in un modo o nell‚Äôaltro, la questione della lingua, significa che si sta imponendo una serie di altri problemi¬ª. Secondo De Mauro l‚Äôinteresse di Pasolini per i linguaggi √® totalizzante: √® un interesse per le ¬´diverse realt√Ý idiomatiche¬ª intese come ¬´altrettante forme di vita¬ª[2].
Attraverso l‚Äôanalisi dei fenomeni e dei mutamenti linguistici, Pasolini realizzava una totale partecipazione alla ¬´realt√Ý in movimento¬ª della societ√Ý italiana dagli anni Cinquanta-Sessanta agli anni Settanta. L‚Äôitinerario del versante linguistico o socio-linguistico della sua ricerca non fa registrare un andamento lineare, √® omologo e speculare al resto della sua opera multiforme, ed √® fatto per questo di abiure, ripensamenti, messe a punto, riprese e rettifiche, ma possiamo sintetizzarlo individuando tre snodi cruciali nel quale si sviluppa tra anni Cinquanta e Settanta. L‚Äôimmersione e l‚Äôamore per la vita popolare, per i dialetti e i corpi del sottoproletariato, vissuti come ¬´infelice antitesi¬ª rispetto alla storia e alla cultura delle classi egemoni, √® lo sfondo dell‚Äôattivit√Ý letteraria e artistica, a vasto raggio, degli anni Cinquanta. I ¬´parlanti¬ª popolari, i giovani ragazzi di vita delle borgate romane rappresentano per Pasolini i portatori sani di valori antagonisti, profondamente alternativi alla borghesia vecchia e nuova uscita dal fascismo e dalla Resistenza (sebbene siano valori gi√Ý destinati alla morte, alla sconfitta, ai rischi dell‚Äôomologazione e del cinismo: si pensi al finale di Ragazzi di vita)
Il 26 dicembre del 1964, su «Rinascita», Pasolini pubblica il saggio Nuove questioni linguistiche (poi raccolto in Empirismo eretico, 1972). Il dibattito suscitato dall’intervento, con le repliche di scrittori come Calvino e Moravia, giornalisti come Andrea Barbato, e le contro-repliche di Pasolini, prosegue fino al 1966.
¬Ý
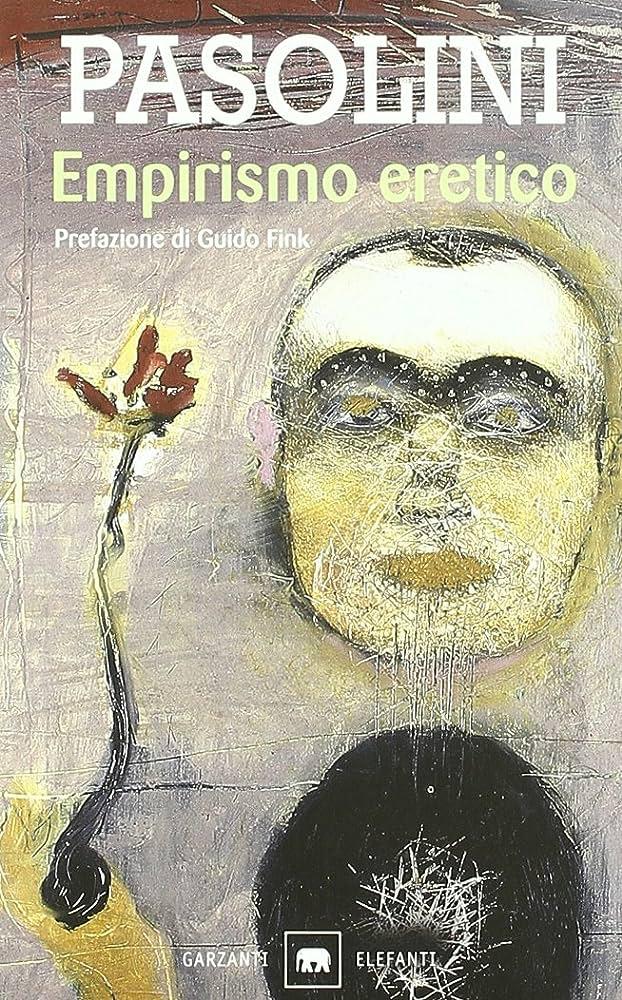
¬Ý
Come √® noto, qui viene abbozzata per la prima volta la sua diagnosi antropologica e politica sull‚ÄôItalia del miracolo economico, esplorandone il rovescio, il lato oscuro del progresso, e dispiegando in questo senso il suo spirito critico e anti-moderno: dagli ideali della Resistenza tradita alla denuncia della mutazione antropologica, ancora una volta Pasolini osservava la nuova realt√Ý dal punto di vista linguistico. Assecondando la vocazione pedagogica, divulgativa e analitica che lo conduceva a stilare una sorta di bollettino socio-linguistico sul suo tempo storico (una specie di Che lingua fa, scriver√Ý in Nuove questioni linguistiche), Pasolini segnalava l‚Äôincombere di una ¬´nuova era dell‚Äôumanit√ݬª, ¬´l‚Äôera della scienza applicata¬ª. √à il tempo del pensiero unico che elegge a valori esclusivi la produzione e il consumo, e che finisce con il generare una neo-lingua omologata, centralizzata, impoverita, irradiata dalle aziende del Nord: ¬´√® nato l‚Äôitaliano come lingua nazionale¬ª. Il trauma si riflette non soltanto sul Pasolini pre-corsaro o proto-luterano, per cos√¨ dire, e cio√® sulla sua scrittura giornalistica e saggistica sempre pi√π percorsa e turbata in questo periodo da un sentimento apocalittico; ma anche, e direttamente, sugli esiti espressivi della sua opera letteraria. Da quel momento, non a caso, lungo tutti gli anni Sessanta, si registra l‚Äôabbandono delle poesie e della prosa narrativa, la coscienza tragica dell‚Äôinutilit√Ý, della crisi cui vanno incontro la lingua, la civilt√Ý e la cultura umanistica tout court. Il passaggio al teatro e al ¬´cinema di poesia¬ª verr√Ý interrotto solo nel 1971 con l‚Äôuscita di Trasumanar e organizzar, che segna il (provvisorio) ritorno alla poesia, una poesia sempre pi√π impoetica, da leggere in dialogo con la saggistica civile degli Scritti corsari e delle Lettere luterane.
¬Ý
2. «Bisogna trovare un nuovo modo di essere»
¬Ý
Il 21 ottobre 1975, infine, nel corso della sua lezione leccese, in Volgar‚Äôeloquio, torner√Ý sulla sua diagnosi socio-linguistica espressa nel 1964 e traccer√Ý il percorso che dal diffondersi di una lingua volgare, ¬´tecnocratica¬ª, aveva portato alla volgarit√Ý della lingua, all‚Äôegemonia incontrastata dell‚Äô¬´Italiano orrendo¬ª. Il sintomo pi√π doloroso di questa mutazione linguistica √® secondo Pasolini il declino e la morte dei dialetti. √à interessante notare come al termine ¬´stingimento¬ª dei dialetti, utilizzato nel saggio del 1964, si sostituisca in Volgar‚Äôeloquio e negli scritti di questo periodo il lemma o il concetto di ¬´annichilimento¬ª: dai centri settentrionali dell‚Äôindustria e delle aziende, individuati in Nuove questioni linguistiche come gli agenti di irradiazione di una lingua omologata e impoverita, l‚Äôobiettivo polemico √® ora trasferito all‚Äôazione della televisione e della scuola, asserviti alla societ√Ý dei consumi, quella che definisce una ¬´forma assolutamente nuova, rivoluzionaria del capitalismo¬ª. Come effetto ormai compiuto del miracolo economico, della scolarizzazione di massa, delle migrazioni interne e della devastazione della civilt√Ý agricola e arcaica causata dagli squilibri infausti di uno ¬´sviluppo senza progresso¬ª, Pasolini denunciava la diffusione ormai pervasiva dei mass media e della cosiddetta societ√Ý dello spettacolo. Negli anni Settanta √® dato per compiuto il ¬´genocidio culturale¬ª, l‚Äô¬´inquinamento¬ª delle classi subalterne ad opera dei modelli distorti e dei falsi valori del consumismo.
Si tratta, scrive in Volgar‚Äôeloquio, di un vero e proprio ¬´accentramento linguistico e culturale¬ª, che finisce con il ridurre al silenzio la pluralit√Ý delle culture popolari e delle altre stratificazioni linguistiche che storicamente avevano dato linfa alla lingua nazionale. √à una diagnosi senza scampo che viene condotta da Pasolini ricorrendo ai registri o alle tonalit√Ý del lutto e dell‚Äôelegia, del lamento funebre per la fine del mondo popolare cui si accompagna la scomparsa dei dialetti, intesi, precisa in Volgar‚Äôeloquio, come ¬´modo di essere e valore¬ª. Le culture marginali non sfuggono all‚Äôassimilazione e al Potere centralizzante e omologatore della mentalit√Ý consumistica borghese. La borghesia verr√Ý concepita non tanto in termini di classe ma come malattia sociale, come nuova costante antropologica del neocapitalismo. A partire dalla constatazione sofferta che i dialetti, insieme ai corpi del mondo popolare e del sottoproletariato, sono per sempre scempiati dal nuovo potere dei consumi, e dopo la definitiva Abiura della Trilogia della vita di cui discorre proprio in un passaggio di Volgar‚Äôeloquio, Pasolini avrebbe avviato la definitiva decostruzione di questo mito impolitico e arcaico, ormai ai suoi occhi anacronistico: quello dei dialetti, delle lingue viventi e della giovent√π narrata nei diari e nelle poesie friulane, nei romanzi romani e nel cinema di poesia degli anni Sessanta e Settanta.
¬ÝNelle prose corsare e luterane e nel suo stile tardo, tra Petrolio e Sal√≤, insieme con la denuncia della riduzione del linguaggio a merce, e della degradazione del corpo a cosa, si affiancava la coscienza della miseria della letteratura, del tramonto della civilt√Ý e della funzione sociale dell‚Äôintellettuale umanistico. Ma pi√π che alla luce della nostalgia luttuosa, del senso di vuoto o della profezia apocalittica e disarmata, la mia proposta √® di rileggere l‚Äôultimo tempo della sua opera, e in particolare le parole del Volgar‚Äôeloquio, ricorrendo alla categoria di pensiero tragico o di ¬´disincanto combattivo¬ª, di chi si sentiva coinvolto, scriveva, in ¬´una lotta fra una cultura che non accettiamo e una cultura che √® finita¬ª. Interrogarsi sulla postura e la retorica utilizzate da Pasolini nell‚Äôultimo tempo della sua opera, nell‚Äôultimo e febbrile periodo della sua attivit√Ý intellettuale, fino alla giornata trascorsa tra Lecce e Calimera dieci giorni prima del suo assassinio, √® un‚Äôoperazione ancora oggi utile e forse necessaria per smentire o complicare produttivamente certi luoghi comuni che ammantano la sua figura, al di l√Ý di ogni stereotipo gravitante intorno alle retoriche del martirio, del profeta disarmato e della beatificazione postuma e apologetica. Sono i logori luoghi comuni, lo faceva notare Pietro Cataldi in un saggio dedicato proprio all‚Äôeredit√Ý di Pasolini, che in questi ultimi decenni hanno paradossalmente contribuito ad alimentare le tendenze a ‚Äúun dissenso organizzato in opinionismo‚Äù e alla trasformazione liberal della funzione intellettuale[3].
¬Ý
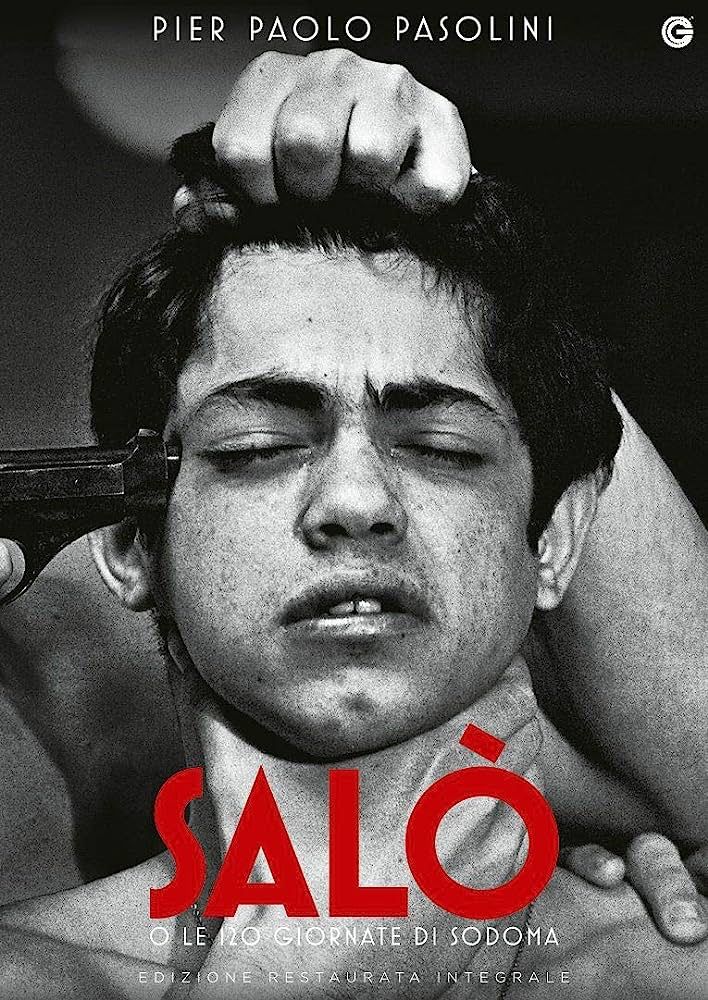
¬Ý
Nel corso del dibattito di Volgar‚Äôeloquio, a vedere bene, Pasolini rifiuta a pi√π riprese l‚Äôetichetta o la fama di ¬´profeta¬ª (¬´non sono un profeta n√© voglio esserlo¬ª, dice a un certo punto); e si presenta piuttosto come un ¬´misero e impotente Socrate¬ª. Adopera gli strumenti retorici del dubbio e della maieutica, puntando al coinvolgimento attivo degli ascoltatori attraverso uno stile argomentativo, non assertivo ma fluido, fatto di esempi e parallelismi. Il tratto stilistico pi√π significativo della conferenza, forse il lemma o il metodo ermeneutico pi√π ricorrente di Volgar‚Äôeloquio √® il paradosso: ¬´Questo √® un altro paradosso [‚Ķ]. Questo lo dico per far vedere che in realt√Ý c‚Äô√® poco da fare¬ª. Sulle orme di Jonathan Swift e del suo pamphlet del 1729 (Una modesta proposta‚Ķ), Pasolini faceva ricorso alle provocazioni come la (non) esistenza di una ¬´destra sublime¬ª, l‚Äôabolizione o la sospensione della Tv e della scuola media, per rimarcare la gravit√Ý della situazione e per rendere plasticamente evidente l‚Äôassenza di vie percorribili di fronte a una crisi epocale e senza futuro, giudicata irreversibile e fatale. Ma √® opportuno sottolineare che la filigrana apocalittica o impolitica del suo impeto pedagogico, almeno nei discorsi di Volgar‚Äôeloquio, si univa a una resistente tensione utopistica che escludeva la rassegnazione e il nichilismo, e che invece testimoniava ancora di un‚Äôapertura sofferta ma tenace al divenire e all‚Äô¬´impensabile¬ª.
Un‚Äôennesima torsione pedagogica, disperata e vitalistica, per proteggere la natura non integrata della funzione intellettuale, che ricorda il pensiero di Walter Benjamin sulla ¬´debole forza messianica¬ª data in sorte a ogni generazione, e che si tratta di ereditare e di esercitare nel migliore dei modi possibili. ¬´Bisogna trovare un nuovo modo di essere [‚Ķ]¬ª, scriveva Pasolini in Volgar‚Äôeloquio, ¬´un nuovo modo di essere progressisti, un nuovo modo di essere liberi. [‚Ķ] Il consumismo mi ha cos√¨ sopravanzato [‚Ķ]; √® un‚Äôassimilazione globale, potente, totalizzante. [...] Per√≤ vorrei ricominciare da capo¬ª: √®, forse, in questo ulteriore ossimoro o paradosso, in questa serie di aporie e contraddizioni senza possibilit√Ý di sintesi armonica tra il razionale e l‚Äôirrazionale, tra la nostalgia e l‚Äôutopia, tra ottimismo e pessimismo, che andrebbe ricercato il significato del suo ultimo eloquio, come attesta l‚Äôennesimo amalgama o palinsesto di scritture che comprendono anche la serie di articoli composti tra il 1973 e 1975, poi raccolti in Scritti corsari e Lettere luterane. Penso in particolare al discorso tenuto alla Festa dell‚Äô¬´Unit√ݬª di Milano e pubblicato su ¬´Rinascita¬ª il 27 settembre del 1974, da cui cito un brano per concludere il mio intervento: ¬´Una visione apocalittica certamente, la mia¬ª, scriveva Pasolini, ¬´ma se accanto ad essa e all‚Äôangoscia che la produce non vi fosse in me anche un elemento di ottimismo, il pensiero cio√® che esiste la possibilit√Ý di lottare contro tutto questo, certamente non sarei qui, tra voi, a parlare¬ª.
¬Ý
¬Ý
[Una versione diversa dell’articolo è stata pubblicata in “Studium”, Vol. 4, 2022, SEZIONE MONOGRAFICA Pasolini a cento anni dalla nascita, a cura di Fabio Pierangeli].
¬Ý
[1]A. Gramsci, Quaderni del carcere, edizione critica dell’Istituto Gramsci a cura di V. Gerratana, Einaudi, Torino, 1975, p. 1696. Su Gramsci e Pasolini: P. Desogus, Lo scandalo della coscienza: note sull’influenza di Gramsci, in Id., Laboratorio Pasolini, Quodlibet, Macerata 2018, pp. 97-115.
[2]T. De Mauro, Pasolini: dalla stratificazione delle lingue all‚Äôunit√Ý del linguaggio, in Id., Le parole e i fatti, Editori Riuniti, Roma 1977, p. 250.
[3] P. Cataldi, Pasolini non √® il fato, in Id., La strana piet√Ý. Schede sulla letteratura e la scuola, Palumbo, Palermo, 1999, pp. 73-85.





