Con questo pezzo sul romanzo di Hermann Hesse si conclude un trittico di Roberto Santoro sui temi della fuga, dell'amore e dell'abbandono: i precedenti articoli erano dedicati a Tondelli e a On the road di J. Kerouac.
ô
Siddhartha, il ô¨poema indianoô£ di Hermann Hesse uscito in Germania nel 1922, û´ uno dei bestseller piû¿ venduti di tutti i tempi. Tre milioni di copie solo in Italia dal 1975, quando Adelphi ripubblica il romanzo dopo aver acquisito il catalogo Frassinelli. Dai tempi della contestazione studentesca allo spiritualismo ãNew Ageã, Siddhartha diventa la bibbia tascabile di chi va in cerca di se stesso in India, quellãOriente dove ô¨pare che gli uomini vengano al mondo con un dono particolare per la speculazione metafisica e la ricerca delle cause ultime,ô£ scrive il musicologo Massimo Mila, che traduce il romanzo mentre û´ detenuto nelle carceri fasciste.
ô
Siddhartha abbraccia una disposizione dellãanimo che Friedrich Nietzsche chiamava ô¨amor fatiô£, locuzione latina che si traduce con ãamore del fatoã. Amore provato da tutte quelle creature, gli esseri umani, che vivono in un mondo dominato dalla sofferenza, e che ogni volta, sbagliando, a furia di passi falsi, riconoscono e accettano con gioiosa consapevolezza lo scorrere delle cose, il loro finire e sempre ricominciare. Nella sua avventurosa esistenza, Siddhartha si immerge in tante vite diverse, tutto ei provûý per dirla con Manzoni, la fuga di casa, la vita sulla strada con i vagabondi samana, lãincontro con il Buddha, lãamore per la bella cortigiana Kamala, successo, ricchezza, disperazione, fallimento economico, un tentato suicidio. Samsara, lãeterno ciclo della morte e della rinascita. Solo verso la fine del romanzo Siddhartha trova pace. Il ãcercatoreã (Der Suchende) si ãrisvegliaã (Bodhisattva, il predestinato allãilluminazione) e sceglie di trascorrere il resto della sua esistenza sul fiume, Gange, Indo, Brahmaputra, un nome vale lãaltro per lãorientalista Hesse. Qui il protagonista si fonde con la natura circostante, in una esperienza panteistica di comunione con il mondo.
ô
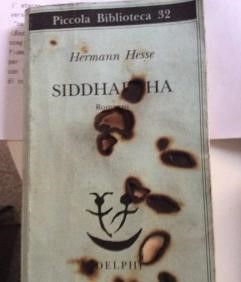
ô
Sul fiume Siddhartha viene accolto e divide le sue giornate con il barcaiolo Vasudeva, personaggio centrale del romanzo se ci interessa comprendere la teoria di Hesse sullãamore. Facciamo un passo indietro: nelle notti di passione trascorse con Kamala, Siddhartha senza saperlo ha messo incinta la bella cortigiana. Quando la donna, anni dopo, ormai invecchiata, attraversa lãIndia insieme al suo bambino per andare a rendere lãestremo saluto al Buddha morente, sul fiume ritrova Siddhartha. Questãultimo scopre di essere padre: immaginiamo la piû¿ alta forma di amore, lãamore per i nostri figli, e i sentimenti contrastanti legati alla scoperta di avere un figlio sconosciuto. La notizia, perûý, û´ che il figlio di Siddhartha detesta suo padre. Lo ritiene noioso, assillante e protettivo, lo tratta malissimo. Siddhartha prova a farsi accettare dal figlio ritrovato, sopporta tutte le bravate, le offese, le stupidaggini del ragazzino, cerca di conquistarlo con pazienza amorevole, ma il figlio a ogni atto di generositû del genitore reagisce con assoluto disprezzo, ignora chi lo ama, lo insulta, lo deride. Siddhartha allora perde la testa. Si strugge. Sbaglia. Insiste. Soffre. Sbaglia di nuovo. Quando il ragazzino scappa di casa rubando la barca di Vasudeva, il padre invece di punirlo si limita a rincorrerlo, solo per nostalgia, pur di rivederlo unãultima volta. Ma il figlio nasconde il remo della barca rubata per impedire al padre di inseguirlo. Un simbolo, questo remo nascosto, come un ramo segato di proposito, della separazione ormai consumata: non venirmi piû¿ a cercare. Mila, il traduttore del romanzo, definisce eroico, quasi ãvichianoã, il gesto di rottura del figlio.
ô
ô¨Tuttavia Siddhartha amava suo figlio e aveva piû¿ caro il dolore e lãaffanno dellãamore, che pace e felicitû senza quel bambinoô£. Non gli era mai capitato di ô¨perdere a tal punto il proprio cuore, non aveva mai amato a tal punto una creatura umana, cosû˜ ciecamente, con tanto dolore, con tanto insuccesso, eppure con tanta felicitû ô£. E dunque ô¨anche questo piacere chiedeva di essere espiato, anche questi dolori chiedevano di essere assaporati, anche queste pazzie chiedevano di essere commesseô£. La ferita continuerû a bruciare per molto tempo e molte altre volte il protagonista del romanzo andrû in cerca del figlio, senza trovarlo. Lãincendio non si spegnerû da sûˋ, scrive Hesse, ma ricordiamoci che Siddhartha non û´ solo. Con lui cãû´ il mite Vasudeva, che tanto mite alla fine non si rivela. Il taciturno, sorridente ma accorto barcaiolo, nel volgere di poche pagine offre al lettore in cerca della consolazione della letteratura una lezione stupenda su come stare al mondo. Lasciamo andare chi non ci ama, non ci ama piû¿ o non ci ha mai amato, dice Vasudeva ricordando a Siddhartha che suo figlio era un ô¨viziatoô£, un ô¨cocco di mammaô£, uno che ha preso ed û´ sparito allãimprovviso. Il fiume se la ride del giovane fuggitivo: ô¨Non sarû poco il suo soffrire, orgoglioso e duro û´ giû il suo cuore, e molto devono soffrire quelli come lui, molto errare, molte ingiustizie commettere, caricarsi di molti peccatiô£. Anche il figlio avrû la razione di pena che spetta a ogni essere umano, dovrû ô¨lordarsi egli stesso con la vita, caricarsi egli stesso la sua parte di colpe, bere egli stesso lãamaro calice, trovare egli stesso la sua viaô£.
ô¨Ahimû´, caro amico, ti vedo soffrire, ma tu soffri dolori dei quali si dovrebbe ridere, dei quali tu ben presto rideraiô£, conclude Vasudeva in un sorriso sornione, gioco û´ lãamore, giochi le passioni e i desideri inseguiti dagli ãuomini-bambiniã.
La storia del figlio di Siddhartha parla a ognuno di noi. Agli abbandonati, ai disprezzati, a chi ha inseguito e provato nostalgia e a chi û´ fuggito in cerca di nuova compagnia. Sotto questo sole estivo, come Siddhartha abbiamo versato chilometri di lacrime ricordando quelle rive, fiume, spiaggia, quella forza che ci teneva uniti mentre risalivamo il bagnasciuga in un pomeriggio di agosto. E adesso? Che faremo adesso che siamo rimasti soli? Qui ci vuole Vasudeva. ãFuttatinã, direbbe il barcaiolo se avesse conosciuto la lingua madre siciliana. Sai che cãû´, adesso tornaci da solo su quelle rive, scegli una spiaggia nuova, siediti, respira e aspetta. La dolcezza delle nuove sensibilitû û´ lû˜ a portata di mano, basta prenderla.
Dãaltra parte ognuno ha le sue responsabilitû in questo mondo, e anche tu che ami, Siddhartha, in passato hai ferito e fatto soffrire, sei scappato senza dare spiegazioni e pretendevi di essere riaccolto a braccia aperte. û lãeterno ritorno, la ruota che gira: il protagonista del romanzo realizza che durante la sua adolescenza si era comportato con suo padre, il vecchio bramano, proprio come ha fatto suo figlio con lui, abbandonando la sua famiglia senza farvi piû¿ ritorno. Che strana commedia û´ la vita, chiosa Hesse.
ô
Forse un giorno il figlio di Siddhartha tornerû a chiedere udienza ã ipotesi remota, visto il tipo; ma quel giorno la nostra pazienza sarû finita, û´ giû finita. La nostalgia raffreddata. Lãamore ritrovato, se mai cãera stato, rivolto altrove. Intanto il fiume continua a ridere di quel figlio ô¨cupo e scontrosoô£ del quale non si û´ saputo piû¿ nulla, ma sembra che persino Siddhartha, un bel giorno, se ne sia fatto una ragione:
ô
ô¨il padre intuû˜ che era un pazzo desiderio quello che lo aveva sospinto fin qui. Egli non poteva aiutare suo figlio, e non doveva attaccarsi a lui. Profondamente sentû˜ in cuore lãamore per il figlio fuggito, come una ferita, e sentû˜ insieme che la ferita non gli era data per rovistarci dentro e dilatarla, ma perchûˋ fiorisse in tanta luceô£.
ô
Per dirla semplice: non sarû che il figlio di Siddhartha era un poã stronzo? Stronzo lui, stronzo io, stronzo il mondo.
û ora di accettarlo per quello che û´, come viene. Amor fati.





